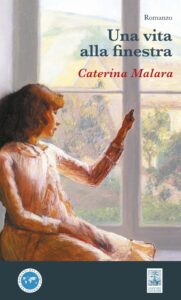
Una vita alla finestra
Anche ‘Una vita alla finestra’ , così come ‘Natalino’ (Guida Editori, 2021), è uno spaccato di come si viveva nell’Italia meridionale, e in particolare in Calabria, nella seconda metà del secolo scorso; descrivere la realtà della propria terra per l’autrice è una missione, iniziata anche grazie al lavoro dell’amica Maria Franco. Anche questo racconto narra di un’esperienza dolorosa che per fortuna, grazie al vaccino dell’antipolio, non è più condivisibile con i bambini di oggi. Grazie ad uno stile semplice e coinvolgente, dove traspare il coinvolgimento emotivo dell’autrice che, inevitabilmente, attiva quello del lettore, il racconto diventa la testimonianza storica di una realtà dolorosa che obbliga a riflettere su di una tematica sempre attuale come quella dell’obbligatorietà dei vaccini.
La storia
La protagonista di “Una vita alla finestra” è una ragazza degli anni ’60 che vive in un paesino della Calabria. Si chiama Silvia M. ed è disabile a causa della poliomielite contratta all’età di due anni. Fino alla quinta elementare, dovendo vivere per lunghi periodi negli ospedali per dedicarsi alla riabilitazione, non ha potuto frequentare la scuola ed ha dovuto prepararsi da privatista. Ovviamente vive sotto l’ala protettrice dei genitori e di tutta la famiglia; scopre per caso cosa le era veramente successo, il nome della sua malattia ed il dolore che aveva portato nel cuore di tutti i familiari, udendo una conversazione del nonno ignaro della sua presenza. La vita di Silvia è dunque ‘monca’ di alcune esperienze fondamentali nella crescita di una persona come l’autonomia e la socializzazione con i coetanei. In prima media può, finalmente, frequentare la scuola dove fa amicizia con un ragazzina che ha il suo stesso nome: Silvia G.
L’esperienza è importante e significativa per lei anche se, mentre da una parte le permette di vivere come gli altri adolescenti, il confronto quotidiano con loro la obbliga a prendere coscienza delle limitazioni che i suoi deficit motori le impongono, e soffre sicuramente come gli altri ragazzi conosciuti nei centri ortopedici di recupero motorio: la poliomielite li ha condannati ad un percorso di vita diverso… comunque, sempre amorevolmente assistita dai genitori e sostenuta dall’amica del cuore fino alla maturità, Silvia prosegue gli studi fino alla laurea. Lo studio riesce a distrarla momentaneamente dai pensieri tristi che la assillano: non si può muovere autonomamente e quindi non si sente libera, non si sente accettata dai coetanei, vive sulla sua pelle la diversità del suo stile di vita rispetto al loro, percepisce il pietismo mieloso ed ipocrita nonché i pregiudizi di una società che discrimina e relega il diverso. Conosce solitudine e momenti di avvilimento che la portano ad isolarsi e chiudersi in se stessa, a disperare di potersi inserire nel mondo del lavoro ed avere una sua indipendenza.
Perché ‘una vita alla finestra’
Il titolo “Una vita alla finestra” descrive la vita della protagonista che per anni assiste alla felicità degli altri osservando, come appunto da una finestra, la loro vita … quella normalità che a lei è stata negata. Il suo sentimento però non è invidia verso le coetanee più fortunate ma è risentimento verso la sorte che le è toccata. Silvia definisce i suoi genitori “illuminati” perché hanno capito quanto il diploma e poi la laurea la aiuteranno nella vita. Ed ecco che arriva una svolta : sostenuta dalla maestra che l’ha seguita nel percorso delle scuole elementari e dalla lungimiranza di suo padre, Silvia diventa resiliente e guarda in faccia la realtà! Avviene un piccolo miracolo di cui deve essere orgogliosa perché da ragazza insicura e timida si trasforma in una donna determinata, forte e con le idee molto chiare sul ruolo che può svolgere nel suo ambiente. Inizia a lavorare in una libreria dove riesce a stimolare l’amore per la lettura e per la cultura ai suoi concittadini, proponendo iniziative che portano i libri tra le mani dei concittadini di tutte le età. Riesce ad acquistare il negozio e ne fa un centro di incontri, discussioni, scambi di opinioni trasformando la piccola libreria di provincia in un attraente centro culturale.
Un testo per le scuole
La lettura di ‘Una vita alla finestra’ potrebbe essere un punto di partenza per la conoscenza non solo dell’evoluzione storica del costume nel nostro paese, ma anche per riflettere sul valore della ricerca scientifica, e della preparazione che essa richiede. Forse la digitalizzazione, insieme ai tanti vantaggi, ha portato anche lo svantaggio del vivere nei tempi del ‘mordi e fuggi’ anche nelle riflessioni: tutto avviene di fretta. Sembra che il tempo di riflettere prima di agire, quello di riuscire ad immedesimarsi nei panni dell’altro, di concentrarsi e riconoscere le emozioni che si vivono e a volte anche la capacità di distinguere la realtà dal virtuale sono tutte cose in via d’estinzione… eppure la scuola lavora tanto sullo sviluppo di queste capacità così come s’impegna perché l’inclusione sia reale. Sarebbe bello vedere le nuove generazioni impegnate nel recupero e nello sviluppo della capacità di pianificare le proprie azioni valutandone le conseguenze in modo consapevole. Sicuramente la lettura di una storia come questa può toccare le corde giuste del cuore dei nostri ragazzi.
 Per conoscere Caterina Malara
Per conoscere Caterina Malara
– questa storia insegna molte cose: come convivere con il dolore, come è possibile riprendersi la vita desiderata, l’importanza dell’amicizia, dell’apertura mentale e della cultura… Era questo il tuo scopo iniziale?
Ho cominciato a scrivere questa storia durante l’epidemia di Covid, quando sentivamo le tante corbellerie dispensate a piene mani dai no vax.
Mi premeva far conoscere le difficoltà, le rinunce e quant’altro comportava ammalarsi di polio e vivere in una condizione fisica limitante. I vaccini hanno dato una svolta importantissima alla vita dell’umanità
– dalla scrittura di “Una vita alla finestra” traspare un tuo forte coinvolgimento emotivo, è il racconto che ti ha preso nel suo svolgersi o un forte riferimento autobiografico?
Io ho ‘prestato’ tanto di me a Silvia: avevo circa due anni quando contrassi la poliomielite, non troppo tempo prima che arrivasse il vaccino quindi conosco bene cosa significa vivere il dolore di certe limitazioni ed ho sentito quasi un dovere morale raccontarle a chi, oggi, ha la fortuna di poter fare il vaccino che fino agli anni ‘60 non c’era.
– Caterina cosa rappresenta per te poter stimolare emozioni narrando storie …
Mi sembra importante e giusto farlo, soprattutto oggi che sembra che il mondo vada all’incontrario. Troppi parlano senza avere le adeguate competenze; il futuro ministro della sanità americano dice che ha intenzione di sospendere la somministrazione di alcuni vaccini (forse anche dell’antipolio) e tanti politici tifano per la vaccinazione su base volontaria… Io faccio ancora in tempo a trasmettere emozioni di prima mano, e devo farlo, devo far riflettere sul fatto che, proprio grazie al vaccino, l’esercito delle vittime della polio si assottiglia. Ci sono malattie di cui è bene conoscere e valutare la gravità dei segni che lasciano prima di rinuncia alla protezione di un vaccino.






